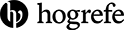Osservatorio Talent
Psicologia in azienda: a che punto siamo?
Psicologia in azienda: a che punto siamo?
Sui palcoscenici dei teatri aziendali stanno andando in scena spettacoli in larga parte noiosi in quanto ripetitivi e privi dei necessari “scatti” di fantasia e di creatività. I registi all’opera per dirigere lo psicologo-attore sembra stiano esagerando nel suggerire atteggiamenti prudenziali. Il falso movimento (o movimento apparente) si sta configurando come il tratto caratteristico di una psicologia del lavoro per lo più sottomessa all’esigenza che con maggior vigore viene espressa dalle committenze aziendali: lasciare le cose come stanno. Senza tuttavia che ciò appaia.
Il che non è sorprendente, in un periodo storico attraversato da una crisi antropologica che viene fatta passare, con studiata superficialità, per crisi economica planetaria. Non possiamo farci niente, paiono sostenere i nostri registi, instancabili nella difesa del culto di una razionalità tutt’altro che razionale. Non è certo il momento di valorizzare le individualità, è il loro grido di battaglia. Importante, viceversa, è determinare le condizioni per le quali le persone al lavoro possano essere gestite come se fossero identificabili con codici a barre desunti dall’applicazione di protocolli sempre più rigidi e proprio per questo sempre meno adatti a leggere le realtà organizzative. L’uni-verso umano, che piaccia o meno, si è trasformato in multi-verso e, in quanto tale, inaccessibile ai tentativi di comprenderne l’essenza adottando ottiche rigidamente paradigmatiche. Una tale prospettiva trova del resto conferma nella sempre più diffusa richiesta di “certificazioni” abilitanti a operare nel campo della selezione, della formazione e della consulenza organizzativa. Il problema, al riguardo, è: ma chi certifica chi ? E quali gli strumenti a tal fine utilizzati?
Tutti coloro che si occupano di organizzazione aziendale (che si sia all’interno o meno della struttura) hanno sperimentato come, per ottenere queste ormai vincolanti “certificazioni”, occorra semplicemente compilare una modulistica tanto farraginosa, quanto espressione di visuali ridotte.
Il curriculum formato europeo, imposto ormai da molti anni, sembra essere la madre di tutto questo proliferare di griglie, moduli e schemi procedurali. Come sempre è accaduto e accade, anche per questo aspetto la critica vigorosa è giunta dal mondo dell’arte e in particolare da Wislawa Szymborska, poetessa polacca Premio Nobel per la letteratura nel 1996: “A prescindere da quanto si è vissuto / il curriculum dovrebbe essere breve. / È d’obbligo concisione e selezione dei fatti. […] Scrivi come se non parlassi mai con te stesso / e ti evitassi. […] Meglio il prezzo che il valore / e il titolo che il contenuto. […] Aggiungi una foto con l’orecchio scoperto. / È la sua forma che conta, non ciò che sente.” (Scrivere il curriculum. In: Szymborska, Gente sul ponte, Milano: Libri Scheiwiller, 1998, pgg. 69-71.)
Ecco il punto: prezzo e non valore. Forma e non contenuto. Il che pare proprio essere la cifra che caratterizza il nostro tempo storico, prima ancora che le dimensioni e i tratti di aziende e organizzazioni che, sia detto per inciso, di questo tempo storico e sociale sono l’inevitabile espressione.
Una vignetta, pubblicata nella Settimana Enigmistica di qualche tempo fa, sintetizza bene la situazione: “Nella nostra azienda l’individualità viene valorizzata a patto che generi profitto”. Profitto è appunto la parola chiave. Il che non sarebbe in sé un male. Ma profitto per farne poi che cosa? Le aziende, come del resto i governi di qualsiasi colore politico, hanno sempre sentito e sentono l’irrefrenabile necessità di ridurre le spese praticando i cosiddetti tagli lineari. E qual è la Funzione che per prima ne subisce le conseguenze? Scuola e Formazione. Vien da chiedersi il perché. Forse, verrebbe da pensare, perché attrezzare culturalmente cittadine, cittadini e collaboratori potrebbe in seguito renderne difficile e complicata la gestione, soprattutto quando i livelli gerarchici superiori non sono a loro volta culturalmente attrezzati come le condizioni richiederebbero.
Come uscirne? Questo è il problema. Essere o non essere psicologi del lavoro?
Vilfredo Pareto, oltre mezzo secolo fa, ebbe a scrivere: “Le azioni provengono dai sentimenti, non dalla logica. La logica si applica a posteriori” (cit. in: Gagliardi, P. (a cura di), Le imprese come culture, ISEDI, Torino, 1986, pag. 280). Ecco allora che la lettura critico-costruttiva dei copioni che vengono di volta in volta messi in scena nei palcoscenici aziendali e organizzativi può agevolmente avvalersi del contributo di quell’area disciplinare che, per l’appunto, ha nelle emozioni e nei sentimenti il proprio focus di attenzione: la psicologia, meglio se “applicata”.
La situazione è tuttavia singolare e curiosa: mentre da un lato vi è larga convergenza nel considerare – per esempio - l’atto di acquisto di un bene o di un servizio, un atto prima di tutto emotivo e solo in seguito logico e razionale, dall’altro, quando si tratta di riflettere sugli aspetti emotivi che caratterizzano i più diversi ambienti di lavoro, si scatena il panico. E per sfuggire a questa specie di terrore paralizzante, si adottano schemi difensivi quali procedure vincolanti, tabelle Excel e infinite proiezioni in Power Point. Il tutto funzionale al rigetto di ogni ipotesi di assunzione di responsabilità individuale: “Mi sono attenuto alle procedure. Non ho fatto altro che impiegare il protocollo cui devo attenermi”. È chiaro che con questa modalità operativa, l’agire creativo, così invocato a parole ma boicottato nei fatti, viene soffocato sul nascere. Viene altresì evitato il rischio di essere travolti dalla dialettica della natura umana e organizzativa, dialettica satura di elementi riconducibili all’affettività.
E la Rete, strumento dalle potenzialità eccezionali, non pare possa aiutarci più di tanto a mettere ordine nella materia. Digitando in Google la voce “psicologia del lavoro”, in 38 secondi si aprono pagine per un totale di circa 3.800.000 risultati. Navigando e aprendo random i vari siti, appaiono per lo più volti sorridenti e rassicuranti di psicologi e psicologhe che, guarda caso, “certificano” di poter affrontare e risolvere le più svariate forme di malessere esistenziale. O proposte di corsi universitari, parauniversitari, seminari, laboratori, tutti anch’essi orientati a fornire gli strumenti per affrontare con spudorata allegria ogni problema che la vita, lavorativa o meno, dovesse presentare ai partecipanti. Garantendo, vien da sé, ogni successo. Nulla, purtroppo, che proponga il dubbio come criterio di validazione di ogni attività finalizzata alla conoscenza dell’altro e degli organismi aziendali. L’impegno corale sembra essere quello di fare propaganda agli spesso stravaganti approcci che la psicologia del lavoro sembrerebbe generare con indubbia fertilità.
Ma allora, si diceva, che fare ? Come garantire l’articolarsi di quella cultura del rispetto (di noi stessi, dei nostri interlocutori, di una verità oggettivamente sfuggente) così carente ai nostri giorni?
Per quanto possa valere la mia esperienza di oltre trentacinque anni di attività svolta in quanto psicologo del lavoro, ecco che – ad oggi – immagino lecito avanzare le seguenti, ulteriori considerazioni.
A fronte dei “saperi” acquisiti nei corsi canonici universitari e post-universitari (essenziali ma per nulla sufficienti a dar conto delle complessità umane così come si manifestano negli ambienti di lavoro), è necessaria la massima e costante apertura a cogliere senso e significato dei micro segnali che ogni corpo vivente tende ad emettere, siano essi persone o organismi aziendali (che sono un insieme di persone). L’ascolto è la formula di massima efficacia operativa, un ascolto libero e fluttuante che consente il passaggio dal pensiero ad azioni efficaci. Il che trova nel Sigmund Freud di Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921) il proprio robusto sostegno teorico: “Un fenomeno, prima di essere spiegato, deve necessariamente essere descritto”. Il che rinvia alla dimestichezza con l’uso dei codici espressivi tipici della specie umana, cioè linguaggio e parola , scritta e “detta”. Corre il compito al riguardo di osservare che nelle facoltà di Psicologia, il maggior numero di esami viene svolto in forma sincopata e scritta attraverso la compilazione di questionari dove vengono proposte domande a scelta multipla. Con il risultato che i nostri giovani colleghi diventano esperti nel disegnare crocette a velocità sorprendente ma molto meno capaci di far creativamente proprie le linee dei saperi disciplinari erogati e così maldestramente “misurati”.
Occorre allora predisporsi a fare uno sforzo personale per impadronirsi di metodologie di osservazione più adeguate al contesto. E questa operazione di “conquista” può avvenire a condizione che si sia spinti da una curiosità che mi piace definire “infantile”: far proprio, cioè, gusto e interesse per la scoperta di tutto ciò che è magari sempre stato sotto gli occhi di tutti ma che mai nessuno ha potuto (o voluto) vedere. Il che è procedura seguita dai bambini fin tanto che il mondo adulto e adulterato non li hanno ricondotti nell’alveo della stereotipia interpretativa.
Chiarirsi poi su quali siano i valori che guidano l’azione dello psicologo in campo, a prescindere dal codice etico che governa (o dovrebbe governare) la categoria. E rendersi personalmente preparati a rinunciare all’incarico nel caso in cui le richieste della committenza aziendale impongano o richiedano un’agire in contrasto con i principi messi in precedenza a fuoco. Tutto ciò potrebbe costare ma senz’altro fa vivere meglio.
Utilizzare infine tutti gli strumenti che sono messi a disposizione del professionista: test, procedure guidate di assessment, questionari e protocolli più o meno strutturati. Ricordando tuttavia che l’osservatore fa sempre parte del fenomeno osservato e che niente e nessuno potrebbe evitare questo respiro di individualità, da intendersi quindi come occasione di grande e positivo valore.