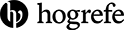Osservatorio Talent
Perchè la Psicologia del Lavoro
Perchè la Psicologia del Lavoro
In qualità di Presidente della Società Italiana di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (SIPLO), abbiamo chiesto al Prof. Pier Giovanni Bresciani di fare il punto con noi sulla figura dello psicologo del lavoro, sulla sua professionalità e sul ruolo che l’associazione svolge per coloro che operano in questo settore. Abbiamo voluto aprire una discussione sugli stereotipi che caratterizzano questa professione, sulle richieste di multidisciplinarietà che caratterizzano l’operato dello psicologo del lavoro e che portano a volte a parziali sovrapposizioni con altre figure professionali, come nell’ambito dello stress lavoro correlato.
D. Lei è il presidente della Società Italiana di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (SIPLO). Qual è la mission dell’associazione?
R. Finalità generale è la promozione, lo sviluppo e la diffusione della psicologia del lavoro e dell’organizzazione come disciplina scientifica e professionale. Facendo appello a una visione della professione nella quale conoscenza scientifica e competenza professionale interagiscono, convivono, e operano in sinergia (modello scientist-practitioner) SIPLO si pone come interlocutore, come luogo di confronto e sviluppo professionale, e insieme come riferimento scientifico-culturale, per quanti svolgono la professione di psicologo del lavoro e delle (o nelle) organizzazioni o ad essa si stanno preparando (i soci ordinari e i soci in formazione); e anche per coloro che, pur non essendo psicologi, operano nelle attività “tipiche” di tale professione, negli ambiti lavoro, organizzazione, risorse umane. L’associazione mette a disposizione un sistema di relazioni, nazionali e internazionali, e un programma di iniziative formative e di aggiornamento, nonché di servizi per lo sviluppo della professione (ad es: accompagnamento alla certificazione Europsy). Sul sito www.siplo.org (di cui è prevista la nuova versione per l’avvio del 2014) è possibile rinvenire tutte le informazioni relative alle attività dell’associazione.
D. La psicologia del lavoro è molto ampia e a volte anche tra professionisti del settore è come se si parlassero lingue diverse tanto possono essere distanti gli ambiti di competenze. Se questo dà una misura di quanto sia vasta l’applicazione della psicologia del lavoro, dall’altro lato a volte rischia di uscirne una professionalità dai contorni poco definiti: secondo lei è così?
R. Anzitutto vale precisare che l’ambito entro il quale si muove lo psicologo del lavoro è propriamente quello della psicologia WOP (Work, Organization, Personnel) che unisce almeno tre dimensioni: l’individuo, il gruppo e l’organizzazione. Lo psicologo del lavoro e dell’organizzazione è quindi chiamato a occuparsi di questioni di per sé ampie e complesse, già solo per l’intreccio tra queste diverse dimensioni. Questo non significa che non ci sia una specificità professionale. Forse, così come è emerso anche dai lavori del recente 2° Congresso Nazionale Siplo, occorre ricostruire, valorizzare e “comunicare” il contributo distintivo e l’identità che la psicologia del lavoro e dell’organizzazione possono mettere a disposizione come risorsa. Una delle strade tracciate, anche a fronte di quello che la letteratura, la ricerca e il confronto avvenuto in sede congressuale suggeriscono, è quella di mettere al centro le persone (dignità del lavoro, empowerment, resilienza, qualità della vita, gestione del presente e progettazione del futuro…), non solo/tanto come singoli ma come gruppi, organizzazioni e comunità. Non credo che esista un problema di confini tra ambiti esclusivi ed escludenti, quanto di specificità e pertinenza dell’intervento a fronte di richieste ed obiettivi chiari ed espliciti. Oggi è diffusa l’esigenza di “contaminazione” professionale, pur nel riconoscimento delle proprie specificità. Non dimentichiamo che la psicologia del lavoro intreccia saperi, competenze e metodi con “altre” psicologie (la psicologia sociale, di comunità, clinica, dell’emergenza, ecc). In questa direzione un esempio emblematico è costituito dall’esperienza di ricerca e intervento nel campo dello stress lavoro correlato.
D. A volte viene fatta una divisione un po’ troppo netta tra psicologia clinica e del lavoro; tuttavia le persone con cui gli psicologi lavorano non sono strutturate a compartimenti stagni. Se da una parte è vero che non si può essere “tuttologi”, non pensa che una maggiore integrazione tra strumenti e conoscenze più cliniche (come l’ascolto empatico o le categorie diagnostiche) e organizzative (ad esempio stress lavoro correlato, dinamiche del mobbing) favorirebbe una miglior comprensione delle persone e delle organizzazioni?
R. È chiaro che la psicologia si nutre di alcune conoscenze e strumenti di base che sono comuni alle “tante psicologie” che esistono, non solo a quella del lavoro o clinica. Richiamo in questa direzione l’articolo 1 della legge 56/89: “la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”. Insisto su questo ultimo punto perché lo psicologo può e deve essere allo stesso tempo un ricercatore e un professionista. Anche in virtù di questo modo di intendere la professione, approcci e metodi che derivano da matrici teoriche differenti possono convivere e trovare spazio all’interno della psicologia del lavoro. La linea di demarcazione tra un intervento di consulenza psicologica clinica e uno non clinico ha dunque a che fare in particolare con gli obiettivi (il contratto) da cui nasce e si struttura il rapporto con l'altro. L’importanza dell’analisi della domanda e del setting di intervento vale sempre, per qualsiasi psicologo che fa uso di tecniche conoscitive e strumenti ascrivibili alle sue competenze: valga per tutti il colloquio. Sebbene alcuni strumenti di analisi e di intervento possano essere gli stessi (es., un test psicologico, tecniche di ristrutturazione, ecc.), l'attenzione del professionista sarà diversamente orientata.
D. Parliamo di stress lavoro correlato. Il D.Lgs. 81/2008 ne ha resa obbligatoria la valutazione. L’impressione che però si ha, a distanza di cinque anni, è che questa legge sia stata vissuta dalle aziende come un obbligo e non abbia sensibilizzato a un maggiore interesse per il benessere dei lavoratori. Cosa ne pensa?
R. Negli ultimi anni il dibattito sulla misurazione del benessere degli individui e delle società è emerso prepotentemente all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale. In questa prospettiva più generale assumono grande importanza le dimensioni della salute e della sicurezza. Tuttavia, le recenti e drammatiche vicende di Prato ci insegnano, ancora una volta, che nessuna norma è forte tanto quanto la necessità di lavorare, a fronte di rischi e costi sottovalutati, se non del tutto ignorati e negati. Ancor prima di parlare di valutazione dei rischi, sia oggettivi sia soggettivi, esiste nel nostro Paese un problema che tocca più profondamente il valore del lavoro come “decent work” così come l’ILO (International Labour Organization) l’ha definito molti anni fa.
In altri termini, sorge il dubbio che se anche la legge e i controlli funzionassero in modo pienamente efficace il numero degli incidenti e delle “morti bianche” non sarebbe necessariamente nullo. Non è quindi solo un problema delle aziende, quanto degli individui e del valore che riconoscono, indipendentemente da ruoli e compiti, alla cultura della sicurezza. E questo vale non solo nella sfera del lavoro, ma anche nella vita privata. Sicurezza è sinonimo di qualità del lavoro e di salute, non come assenza di malattia, ma come ricerca di un miglior benessere. Questi concetti non sono scontati neppure in Paesi evoluti sul piano socio-economico e normativo come il nostro. L’esperienza lo evidenzia tutti i giorni, anche senza arrivare a casi limite. A titolo esemplificativo cito i dati della ricerca ESENER che ha realizzato 36000 interviste a organizzazioni del settore pubblico e privato con 10 o più dipendenti nei 27 Stati membri dell'UE. Tra i fattori preponderanti che spingono ad affrontare la gestione della stress su lavoro si menzionano i livelli di consapevolezza e di definizione delle priorità, l’impegno della dirigenza e la partecipazione dei lavoratori. Potremmo dire tutti fattori che rinviano a variabili di ordine psicologico: e, tali variabili, è dimostrato che sono particolarmente permeabili ad alcune variabili organizzative sulle quali le politiche di gestione manageriale possono molto, in negativo o in positivo. Fa ben sperare che la principale campagna mondiale in materia di sicurezza e salute sul lavoro “Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi”, promossa dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), si concluda registrando un livello record di partecipazione.
D. Parliamo ancora di stress lavoro-correlato. La legge non è stata così rigorosa nel definire gli ambiti di competenze dei diversi professionisti. Uno degli effetti collaterali è stato che tutti hanno fatto un po’ tutto e che c’è stato un improvvisarsi esperti di stress anche da parte di figure non specializzate. Pensa che questa tendenza andrà scemando grazie a una sorta di “selezione naturale” oppure resterà un effetto collaterale?
R. Su questo punto sarò sintetico. La logica della multi-professionalità sta diffondendosi, in alcuni ambiti, come prassi. Non solo nelle organizzazioni sanitarie. L’integrazione di competenze plurime è una risposta alla multi-causalità e alla complessità dei problemi da affrontare, e richiede come requisito una solida identità e una reciproca riconoscibilità professionale. Per incidere sulla cultura in materia di sicurezza e salute diventa fondamentale l’apporto di diverse professionalità, purché ovviamente esperte e specializzate.
D. Sembra che gli psicologi del lavoro soffrano di una sorta di complesso di inferiorità verso altri professionisti, come gli economisti o i consulenti del lavoro. Non è raro quindi vedere professionisti psicologi che si affannano a rincorrere le competenze altrui, perdendo di vista il valore aggiunto che lo psicologo può dare in quanto tale. Cosa è possibile fare per evitare questa situazione?
R. In questa direzione cito l’Osservatorio sulla professione attivato presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi che è nato proprio per dare risposta a esigenze di natura conoscitiva in relazione alla situazione del mercato professionale degli psicologi e agli sviluppi dei bisogni psicologici della popolazione. Uno dei dati emersi, più rilevanti, è che la psicologia genera una pluralità di professioni “on the road”, ovvero di contesti professionali eterogenei e in forte dinamismo storico. Come ho già sottolineato in precedenza, si tratta di affinare adeguate strategie di marketing e di job design delle professioni rispetto ai loro contesti di esercizio. La ricerca svolta da Gfk Eurisko per l’Ordine Nazionale degli Psicologi nel 2009 evidenzia che gli psicologi hanno una rappresentazione delle proprie pratiche professionali non solo plurale, ma anche frammentata e incerta. In concreto, gli psicologi non sembrano avere un frame of reference della professione sufficientemente condiviso e abbastanza semplice da poter essere comunicato chiaramente all’esterno. Questo elemento si è ulteriormente complicato a fronte delle crescenti difficoltà dell’inserimento e alla diffusione dei casi di multi-lavoro. Leggendo questo fenomeno come una condizione di ripiego transitoria, è anche vero che tale considerazione apre a un altro dato della ricerca. Ovvero, che gli psicologi del lavoro seguono progetti professionali diversificati perché i contesti elettivi in cui operano (le organizzazioni, i gruppi e le comunità) sono sempre più fluidi, mobili, difficilmente decodificabili e carichi di nuove problematicità.
D. In Italia sembra esserci una generale tendenza implicita a ritenere che un qualsiasi uomo d’azienda con un po’ di esperienza possa arrivare a fare tranquillamente ciò che può fare uno psicologo del lavoro. Come mai secondo lei?
R. Mi risulta difficile valutare quanto sia una tendenza diffusa, seppure implicita, o quanto l’opinione di pochi critici “sbrigativi”, magari anche poco informati sulla professione dello psicologo. Per certo esistono stereotipi e pregiudizi legati a qualsiasi professione che possono alimentare rappresentazioni parziali o distorte. In tal senso sarebbe importante avere dati di ricerca a conferma o disconferma di questa eventuale visione. Penso altresì che un uomo d’azienda dotato di qualità e capacità gestionali “evolute” sul piano della relazione possa fare egregiamente il suo mestiere: si tratta forse di capire quale sia il suo mestiere, prima ancora che fargli fare quello dello psicologo. Un “qualsiasi uomo d’azienda” non può fare lo psicologo se non è abilitato a esercitare questa professione, ma può pensare di esserlo come può pensarlo qualsiasi essere umano. D’altro canto sempre più si utilizzano termini psicologici, e questo lo si evince dalla comunicazione dei media, dal numero crescente di pubblicazioni in ambito manageriale che fanno uso di concetti psicologici e dall’utilizzo di vocaboli psicologici per spiegare il comportamento dei lavoratori. Usare il linguaggio psicologico o adottare strumenti di tipo psicologico non significa in alcun modo fare l’attività propria di uno psicologo. Più chiaramente credo che un “qualsiasi uomo d’azienda” possa crescere nel suo ruolo e nella sfera delle sue competenze, anche grazie al contributo di un bravo psicologo del lavoro. E credo, in coerenza con ciò che affermiamo su altri temi, che un contro è lo “psicologo di professione”, un altro conto è un soggetto che abbia acquisito progressivamente, nel proprio percorso, qualcosa dell’ordine delle “competenze psicologiche”: ciò è sempre possibile, naturalmente.
D. Un atteggiamento pregiudiziale nei confronti della psicologia del lavoro fa sì che questa venga percepita da psicologi che lavorano in altri contesti, soprattutto clinici, come una disciplina meno importante o di minore dignità scientifica rispetto alle altre branche della psicologia. Le è capitato di confrontasi con un simile pregiudizio? A che cosa crede possa essere dovuto?
R. Mi ricollego alla risposta precedente per sottolineare che anche all’interno della stessa professione si possono insinuare stereotipi o pregiudizi. Sebbene non abbia evidenze così nette sul fronte della ricerca, l’esperienza mi dice che in questa lettura via sia una certa dose di verità. Dai dati di una ricerca promossa dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia a metà degli anni 2000, era emerso che gli ancoraggi professionali ancora oggi dominanti vengono dalla psicoterapia e dai servizi sociosanitari, anche se le concrete possibilità d’impiego appartengono piuttosto ai cosiddetti “mondi professionali minori”: lavoro, marketing, formazione e scuola.