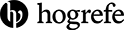L'intervista
Intervista a Santo Di Nuovo
Intervista a Santo Di Nuovo
Il Prof. Di Nuovo è nato a Catania nel 1950, si è laureato nel 1972 in Filosofia e nel 1976 in Psicologia a Padova. Professore ordinario dal 1990 di metodologia all’Università di Palermo e poi di Psicologia generale in quella di Catania. Attualmente insegna Psicologia dei test e Psicologia cognitiva e neuroscienze. È autore di numerosi articoli scientifici su riviste italiane e internazionali e volumi.
Al Prof. Di Nuovo abbiamo chiesto di condividere con noi la sua esperienza di metodologo, riflettendo sulle finalità con cui gli psicologi si accostano al campo della metodologia e della ricerca e psicologia, sulle modalità che i clinici utilizzano per condurre la ricerca, sul rapporto tra ricerca e pratica clinica e su limiti e rischi che devono essere tenuti in considerazione nell’esercizio della professione di psicologo, sia esso clinico o ricercatore.
D. Dal nostro punto di vista, cioè di chi fa della statistica e della metodologia un cardine imprescindibile del nostro lavoro nella psicologia applicata, ci sembra che mediamente tra i colleghi ci sia l’opinione comune e diffusa che la statistica non sia necessaria per un lavoro quotidiano “sul campo”, riservandola a conoscenza per i ricercatori. Ha anche lei questa impressione? Se sì, cosa ne pensa?
R. Considerare che la ricerca (e quindi la sua valutazione, inclusa la statistica) è affare solo dei ricercatori di professione è storia antica. Ricordo, perché mi colpì molto negli anni della mia formazione come ricercatore, un saggio degli anni ’70 dal titolo emblematico “L’applicazione della psicologia sociale alla pratica clinica” che concludeva: Abbiamo bisogno di studi controllati sulle relazioni teoriche, e abbiamo bisogno di una cornice teorica per operare come clinici. Ma il clinico non deve compiere egli stesso questa ricerca. Deve tenersi informato su di essa. I ricercatori di base e i clinici stanno in un rapporto funzionale, simbiotico. Gli uni tracciano i principi generali; gli altri li applicano al mondo reale".
Questa separazione tra “chi fa” e “chi fa ricerca” è ancora iscritta nella mente di tanti colleghi. Però i tempi sarebbero maturi per superare la tradizionale dicotomia tra ricercatori di base e operatori (educatori, riabilitatori, terapeuti) che applicano i risultati della ricerca. Lo dimostrano tanti interventi e relazioni a convegni presentate da psicologi che svolgono la loro professione e riflettono scientificamente su di essa, magari collegandosi – ma senza alcuna subalternità – a chi fa per professione il ricercatore in ambito universitario, con esiti proficui e spesso pregevoli.
D. Si riferisce ad una figura che avvicini l’anima dell’operatore a quella del ricercatore?
R. Oggi si può pensare ad una figura di operatore-ricercatore capace di abbinare alla propria prassi la logica scientifica della ricerca-azione. Logica che permette di fondare scientificamente il proprio operare senza scindere artificiosamente il momento in cui si fa ricerca (in laboratorio? ma qual è il laboratorio della pratica, se non la pratica stessa?) e quello in cui se ne “applicano” i risultati.
Se la statistica è utile come supporto a questa logica, ben venga: qualunque operatore può apprenderne i principi di base e le tecniche essenziali per le proprie verifiche (non servono in questo caso analisi sofisticate…), poi un semplice programma di statistica che si trova shareware sul web o le formule contenute nei consueti fogli di calcolo consentono ormai agevolmente di provare a “passare alla pratica”.
Detto questo, è però anche vero che in certi campi e in certi ambiti di ricerca la statistica non è l’unica modalità di verifica: per esempio, nei modelli a base-line con analisi di variabili nel tempo a seguito di fasi alternate di trattamento e sospensione di esso, si può procedere con analisi visive (anche se le statistiche esistono come verifica ulteriore). Le valutazioni di efficacia a volte prescindono da analisi statistiche, almeno intese in senso tradizionale. L’importante è che la verifica sia “scientifica” cioè rigorosa nel metodo e controllabile dall’esterno: e questo chiunque operi in campo applicativo (educatore, riabilitatore, terapeuta, psicologo delle organizzazioni, ecc.) deve riconoscerlo e, per quanto possibile, attuarlo anche se non fa il ricercatore di professione. La verifica sistematica e metodologicamente corretta del proprio operato fa parte della deontologia di qualunque professionista.
D. Parliamo di ricerca in psicoterapia, e in particolare dello studio degli outcome e dei processi. Quali diverse implicazioni hanno per il clinico?
R. Se la ricerca mira a valutare l’outcome del trattamento, quindi la sua efficacia, centra l’attenzione sugli esiti e gli effetti sul cliente. Valutare il modo di funzionare e l’efficienza del processo terapeutico è cosa diversa, ma non necessariamente contrapposta alla prima: si può valutare se l’intervento funziona e se funziona nel modo più economico e proficuo (in termini di tempo, di risorse, di tecniche usate). Le implicazioni per il clinico stanno soprattutto nel “cosa osservare e valutare” nei due casi.
Nello studio degli esiti l’oggetto della valutazione saranno i tratti di personalità, i “problemi” di cui il cliente (individuo, famiglia, gruppo) è portatore, da osservare prima e dopo il trattamento, ed eventualmente in follow-up per valutare il mantenimento dei risultati raggiunti.
Nel secondo caso occorre un monitoraggio continuo o periodico di ciò che avviene durante la terapia, quindi nell’interazione fra cliente e terapeuta.
Riguardo gli esiti si possono prendere in considerazione parametri generali e svincolati dallo specifico modello di riferimento, e quindi si possono confrontare modelli diversi rispetto ad esiti analoghi (ad esempio, la diminuzione di sintomi depressivi, di ansia da prestazione, ecc.). Nella valutazione “di processo” i criteri devono essere congruenti al modello seguito, in quanto prendono in esame variabili specifiche quali le tecniche usate, il tipo di relazione che si instaura col terapeuta, la sua maggiore o minore direttività, la presenza di prescrizione o “compiti a casa”, cioè di lavori da svolgere tra una seduta e l’altra, ecc. In questo caso è possibile solo una valutazione intra-modello,o addirittura intra-terapia, cioè relativa allo specifico processo che si realizza tra quel cliente e quel terapeuta. La generalizzazione dei risultati si può ottenere con tecniche di cumulazione, anche di casi singoli, ed è per questo che la meta-analisi (analisi cumulativa di risultati ottenuti in studi diversi con analoghe caratteristiche) è lo strumento più usato oggi nella ricerca sulla psicoterapia, per dare un senso complessivo all’oggetto di ricerca in esame.
D. La psicologia è una delle scienze in cui il ricercatore ha il compito di dimostrare che l’intervento proposto produce un effetto statisticamente significativo, partendo dal presupposto che l’azione proposta sia inefficace. È l’approccio della “falsificabilità dell’ipotesi nulla”. Come mai ha preso campo questo modo di analizzare i fenomeni?
R. La ricerca della significatività nella verifica di una ipotesi si basa sull’approccio statistico fisheriano, che è quello più comunemente usato, congiunto alla logica popperiana della disconferma come base della scientificità (che dovrebbe valere non solo per psicologia, ma per tutte le scienze empiriche!).
Il fondamento della decisione di accettare o respingere l’ipotesi nulla, secondo cui l’effetto sperimentale non è rilevante, sta nella previsione che l’effetto delle variabili indipendenti su quelle dipendenti – controllate le variabili intervenienti e quelle di “disturbo” - non sia diverso da quanto ci potrebbe attendere sulla base del puro caso. Una decisione basata esclusivamente sulla probabilità, su una “scommessa contro il caso”, e su una soglia di accettabilità decisa arbitrariamente (il 5%, o l’1% se vogliamo essere più rigorosi, di margine di errore). In conseguenza di questa decisione, si arriva al rifiuto o alla accettazione della ipotesi alternativa, l’ipotesi di ricerca secondo cui invece l’effetto si è verificato in misura superiore ad ogni ragionevole dubbio di casualità.
Questo modello di verifica è utile – e per questo si è affermato in modo generalizzato – quando le variabili interferenti sono poche o controllabili, per cui l’analisi statistica probabilistica ha buone possibilità di tenerne conto in modo attendibile. Entra però in crisi quando le ipotesi da verificare riguardano quelle che, semplificando, possiamo chiamare sperimentazioni “applicative”: non perché si contrappongono necessariamente a quelle “di laboratorio”, ma perché in esse si verificano condizioni specifiche. Condizioni di particolare complessità, in cui le variabili sono tante e agiscono tutte contemporaneamente senza poter essere scisse artificialmente a scopo di ricerca, e per lo più la loro azione si protrae nel tempo se lo studio ha carattere longitudinale.
E anche lo scopo della verifica è diverso. Per un clinico ha poca rilevanza pratica la riduzione statisticamente significativa dei valori pressori di un gruppo di gestanti ipertese se essi restano comunque tanto elevati da costituire un fattore di rischio; allo stesso modo per chi si occupa di disturbi dell’apprendimento è poco rilevante che un gruppo di “cattivi lettori” migliori significativamente – in termini puramente statistici - le proprie prestazioni se i criteri minimi di rapidità correttezza e comprensione nella lettura non vengono comunque raggiunti in relazione all’età e al grado scolastico dei soggetti.
D. Fare riferimento unicamente alla significatività non rischia di allontanare dal senso dei fenomeni osservati?
R. Se un trattamento deve essere davvero utile per i professionisti che lo applicano, non basta che sia statisticamente significativo (significant): deve avere effetto abbastanza grande da essere rilevante (meaningful). Nella statistica attuale la logica della dimensione dell’effetto (effect size) risponde proprio a questa diversa esigenza di verifica, ed è la base per le cumulazioni di effetti come si suole fare nelle meta-analisi, gli strumenti metodologici oggi più usati per fare il punto sulle conoscenze scientifiche e sulle loro applicazioni.
Quanto detto può estendersi ben oltre i confini della psicologia clinica, tradizionalmente legata a modelli di verifica delle ipotesi diversi da quelli sperimentali, per esempio nella valutazione dell’efficacia dell’intervento psicoterapeutico in termini sia di esito che di processo.
Meaningfulness vuol dire cercare nei dati un significato più che una significatività: che è quello utile alla sperimentazione che si sta conducendo, ai suoi utenti, ai suoi committenti. Non solo alla pubblicazione su una rivista scientifica, per la quale interessa prevalentemente la significatività.
D. Sempre di più si parla di Evidence based; prima di investire su un certo tipo di intervento le istituzioni vogliono sapere se questo ha prodotto delle evidenze circa la sua efficacia oppure no. Ma cosa si intende per efficacia?
R. Evidenza è un termine equivoco, perché dipende da cosa intendiamo per ricerca, e – al fondo – per scienza. La scienza è solo quella sperimentale? Qualcuno ancora crede così, dimenticando che tante discipline come l’astronomia, la matematica e la fisica teorica, sulla cui scientificità nessuno dubita, non sono sperimentali. Secondo il positivismo, le spiegazioni scientifiche andavano limitate all’enunciazione di proposizioni riconducibili a fatti tangibili e studiabili empiricamente. Questo ha portato ai metodi riduttivistici e basati sulla pura causalità lineare, che le teorie della complessità hanno radicalmente messo in discussione. Scienza è una prassi di ricerca sulle regolarità e le differenze nei fenomeni, condotta in condizioni controllate, con procedure attendibili e internamente coerenti, e controllabili dall’esterno. Conseguentemente, evidenza non è solo quella sperimentale ottenuta con metodi tipici del laboratorio in cui le variabili possono essere scomposte e studiate analiticamente al riparo delle variabili intervenienti o “di disturbo”.
L’integrazione tra l’analisi dei dati e quella dei significati – lo abbiamo detto poco fa – è la sfida attuale della ricerca contemporanea: i dati non sono l’elemento unico o primario che costituisce la scienza,ma elementi verificabili intersoggettivamente che vanno prodotti e interpretatialla luce di una teoria e di un modello, e solo in questa luce hanno senso. La sperimentazione di laboratorio – per quanto raffinati siano i metodi e avanzate le tecnologie che la sostengono – trova limiti invalicabili se non viene affiancata da un approccio ermeneutico in grado di cogliere nella loro interezza la persona normale e patologica, le relazioni interpersonali e sociali, le organizzazioni e il collettivo, la normalità e la devianza. Su questa evidenza ermeneutica andrebbe valutata l’efficacia della ricerca e degli interventi. Altrimenti il binomio efficacia-efficienza diventa l’alibi per la “razionalizzazione” (chiamiamola eufemisticamente così) dei servizi, specie di quelli sociali e sanitari. I risultati di molti interventi di prevenzione non sono sempre evidence based a priori, perché le evidenze esistenti si riferiscono a contesti e situazioni molto diverse da quella specifica in cui bisogna programmare l’investimento finanziario; ne deduciamo l’abolizione del finanziamento? Ci sono campi – per esempio l’immissione di un farmaco sul mercato – in cui l’evidenza deve essere rigorosamente dimostrata coi metodi tradizionali, altri in cui l’evidenza ci vuole ma deve basarsi su altre logiche.
D. Il DSM-5 sembra sancire un po’ il ridimensionamento del modello meccanicistico e tassonomico riconoscendo il valore dell’approccio dimensionale e fenomenologico. Sta cambiando qualcosa nel modo di leggere la psicopatologia?
R. In molti ambiti tra cui quello clinico oggi si ritiene possibile (anche se non si può dire si stia affermando) una nuova fenomenologia che include il metodo empirico come momento e strumento specifico, all’interno di un’ottica che privilegia la comprensione dei fenomeni, ma che per far ciò si avvale anche di dati rigorosamente ottenuti ma senza assolutizzarli come gli unici in grado di dare una conoscenza scientifica. In ottica fenomenologica si sospende il “pre-giudizio” – nel senso letterale del termine – derivante da teorie, schemi, diagnosi, etichette, che costringono in una forzata categorizzazione il fenomeno unico che si ha davanti. Ma questa sospensione – epoché la chiamavano i filosofi – non è nel vuoto, bensì nella ricchezza di dati (di laboratorio, di osservazione, derivati da metodi qualitativi) che vanno interpretati in un’ottica cumulativa e di generalizzazione sistematica, per comprendere più che spiegare la realtà che ci sta davanti. Il DSM è sempre stato il prototipo di ciò che si dovrebbe mettere tra parentesi: la diagnosi su basi statistiche-nosografiche, utile certamente per alcuni fini (certificazioni, valutazioni in campo peritale, ecc.) e per uniformare il linguaggio tra specialisti; ma inutile, anzi pregiudiziale, per capire la persona che ci sta davanti con il suo (mal)essere-nel-mondo. Non credo che la logica del DSM si possa convertire radicalmente, visti gli scopi a cui serve; si può ragionevolmente integrare con altre logiche, e sta all’operatore preparato farlo nel suo lavoro quotidiano, andando oltre le etichette, quindi chiudendo il manuale diagnostico-statistico per aprire la conoscenza diretta dell’interlocutore che ci chiede qualcosa con la sua sofferenza.
D. I test psicologici, ossia metodologie oggettive standardizzate che forniscono dati che lo psicologo deve essere in grado di rendere qualitativamente rilevanti. Eppure, punteggi, soglie, cut off sembrano spesso utilizzati in modo automatico e acritico, senza chiedersi che senso abbia un determinato punteggio in sé e soprattutto rispetto alla persona che lo ha ottenuto. Cosa rischiano gli psicologi, dal punto di vista della credibilità professionale?
R. Per i test vale lo stesso discorso fatto prima. I punteggi standardizzati e il confronto con le norme statistiche (riferite alla prestazione della popolazione media) collocano la persona in un certo livello all’interno della valutazione nosografica. Per certi usi (QI per l’assegnazione del sostegno, dichiarazione della capacità di intendere e volere, ecc.) questo va bene; per altri usi (capire se una coppia è idonea all’adozione, valutare se un detenuto può essere “messo in prova” all’esterno, programmare un trattamento riabilitativo) serve altro. Serve una valutazione non puramente psicometrica ma qualitativa, o “dinamica” come si suole dire oggi, dopo le intuizioni di Feuerstein sulla valutazione della disabilità intellettiva (che peraltro le aveva riprese dal metodo piagetiano): per riabilitare un bambino con ritardo rilevante, o un anziano con deterioramento cognitivo, non mi serve collocarlo sulla scala psicometrica del QI, dove otterrebbe il classico “profilo piatto”; piuttosto devo formulare un profilo idiografico delle abilità residue, su cui fare leva per l’intervento, e degli obiettivi realisticamente raggiungibili con l’intervento stesso.
In alcuni casi serve un test criteriale mirato ad un obiettivo specifico e contingente alla persona in esame, piuttosto che ad uno standard quantitativo riferito alla popolazione generale: è il caso delle prove sui pre-requisiti di un certo apprendimento, per esempio la lettura. Quali sono le abilità che il bambino deve possedere per leggere? Quali possiede e quali no? E se no, in che grado? In zona prossimale alla meta come diceva Vigotskij, o ancora molto lontano? Per quali abilità occorre iniziare subito un percorso abilitativo, prima ancora di avviare il processo di lettura vero e proprio? I test criteriali mirano a questo, e per questo scopo sono utilissimi. Altra cosa è il test di velocità, correttezza e comprensione della lettura che su basi psicometriche deve dire dove si colloca il bambini rispetto agli standard per la sua età e il suo livello scolastico.
In questo campo, che è specifico della psicologia, lo psicologo rischia molto rispetto alla sua credibilità professionale, se utilizza punteggi, soglie e cut-off senza rendersi conto dello scopo della sua valutazione e quindi dello specifico metodo (e relativo strumento) da privilegiare in quel caso.
D. Lei ha studiato tanti fenomeni psicologici e lavora in tanti ambiti della psicologia. Qual è l’ambito disciplinare che le interessa e la appassiona di più?
R. Il mio lavoro in tanti ambiti della psicologia deriva dalla passione per la metodologia, che mi accompagna fin dagli inizi della mia carriera accademica. La metodologia, e l’approfondimento delle tecniche che ne conseguono, non può limitarsi ad un solo campo di applicazione: richiede una validazione provandola in tanti settori diversi, dal laboratorio sperimentale, all’educazione-rieducazione, alla clinica, fino alla simulazione su reti neurali che mi attrae molto in questo momento perché mi dà la possibilità di verificare modelli e metodi (e loro applicazioni pratiche alcune prevedibili altre imprevedibili a priori) che non si potrebbero testare in altro modo. Una scommessa per il futuro della metodologia, ma anche dell’epistemologia e del senso stesso della ricerca psicologica, e delle sue ricadute applicative “socialmente utili”. Ma di questo potremmo parlare un’altra volta.