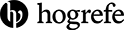Tema del mese
Il Natale non è più quello di una volta?
Il Natale non è più quello di una volta?
Il Natale non è più quello di una volta?
Fra i luoghi comuni più diffusi sul Natale, c’è sicuramente quello per cui la festa avrebbe oggi perso i suoi antichi e originari significati. Come il tempo, i sapori e i giovani, anche il Natale non è più quello d’una volta. La colpa sarebbe del consumismo. Tutti presi dalla voluttà effimera degli acquisti e dei consumi vistosi, ci dimenticheremmo dei valori e dei sentimenti. I sentimenti religiosi, prima di tutto: quasi ci scordiamo che il Natale celebra la nascita di Cristo. Ma anche i sentimenti laici di generosità e altruismo (“siamo tutti più buoni”), soffocati dall’edonismo. Lo stesso spirito del dono, che caratterizza più di ogni altro aspetto la festa, sarebbe vanificato dalla preminenza di un rapporto utilitaristico con il mercato.
Ho usato il condizionale perché non credo affatto che le cose stiano così. O meglio: come molti luoghi comuni anche questo non è un’interpretazione del fenomeno, ma parte del fenomeno stesso che vogliamo interpretare. Se il Natale è per noi un rito importante, lo è in virtù e non malgrado la sua immersione nell’ambito delle strategie di consumo. Che ci piaccia o no, il consumo di massa è una dimensione pervasiva e centrale della nostra vita sociale. È sullo sfondo di questa dimensione che noi costruiamo le nostre identità e le nostre relazioni sociali, e di conseguenza i nostri riti. Cerco di spiegarmi meglio partendo proprio da quest’ultimo punto. In che senso il Natale è un rito?
Che cos’è un rito. Secondo le definizioni più classiche, a partire da quella di Emile Durkheim, il rito è una pratica sociale che si caratterizza per il riferimento a una dimensione “sacra”, nettamente distinta da quella “profana” che caratterizza l’ordinario e il quotidiano. I riti religiosi hanno lo scopo di aprire un canale comunicativo diretto con il sacro, inteso come dimensione divina e sovrannaturale. Ma per la tradizione di pensiero sociologico e antropologico il sacro, indipendentemente dal linguaggio che usa e dalle credenze che adotta, rappresenta la dimensione sociale. Nel rito si ha cioè esperienza del gruppo, della collettività o della società, come qualcosa che trascende l’isolamento individuale. Il rito è dunque un momento che alimenta le relazioni sociali, e funziona in questo modo anche quando non fa riferimento a una dimensione esplicitamente religiosa. Nelle moderne società secolarizzate i riti non smettono di esistere, ma assumono forme e linguaggi diversi, ad esempio quelli di una “religione civile”, della politica, della mondanità, e persino delle attività di tempo libero. Tuttavia restano contraddistinti da alcune caratteristiche. Primo, istituiscono un tempo e uno spazio particolari, qualitativamente diversi da quelli ordinari. Secondo: fanno riferimento a un qualche tipo di “mitologia”. Terzo: implicano esperienze di particolare intensità emotiva, anch’esse distinte dalla più comune quotidianità (le esperienze che Durkheim chiamava di “effervescenza collettiva”). Quarto: prevedono spesso forme di scambio di beni e di consumi collettivi che non seguono le regole comuni, ad esempio caratterizzati da smodatezza, sperpero, condotte libere o sfrenate. Sono presenti queste caratteristiche nel nostro modo di vivere il Natale? Ragioniamoci – interrogando la nostra stessa esperienza di attori sociali – punto per punto.
Lo spazio e il tempo natalizi. Non c’è dubbio, intanto, che il Natale rappresenti uno tempo extra-ordinario, percepito da ciascuno di noi come più “ricco” e significativo del tempo “normale”. Lo aspettiamo tutto l’anno, è una festività demarcante (tra un “prima” e un “dopo”); contiamo i giorni che dal Natale ci separano (si pensi alla fortuna dei calendari dell’Avvento), segnaliamo simbolicamente la “vigilia” e ci facciamo trovare ritualmente preparati al suo arrivo. Ci ricordiamo di solito che cosa abbiamo fatto nei Natali precedenti, e con chi li abbiamo passati. È considerato triste passare il Natale da soli, ad esempio, mentre non ci poniamo affatto questo problema in giorni più comuni. Per quanto possiamo esser cinici e disillusi, non possiamo negare di percepire una qualche “magia” nel tempo natalizio. Ad essa contribuisce naturalmente la creazione di uno spazio particolare, per mezzo degli addobbi. Quelli pubblici, che cambiano l’aspetto delle strade e delle piazze, e soprattutto quelli domestici, con alberi di Natale, presepi, vischio, pacchetti e confezioni regalo e così via.
Mitologie del Natale. C’è una mitologia legata al Natale? Naturalmente sì, ed è in parte quella cristiana, con i racconti sacri della Natività e le rappresentazioni del Presepe; ma nella cultura occidentale moderna è soprattutto la mitologia profana legata alla figura di Babbo Natale. Santa Claus con la sua barba bianca e l’abito rosso, le renne e la slitta volante, il carico di doni consegnati ai bambini e tutto il resto. È noto che Babbo Natale è una figura piuttosto recente, plasmata nella società borghese dell’Ottocento – più precisamente in quella americana, almeno nella sua iconografia attuale, che risale a un disegno del 1863 di Thomas Nast e soprattutto a una pubblicità della Coca Cola degli anni Trenta del Novecento (anche se il nome Santa Claus deriva dalla figura di San Nicola, esportata in America dagli olandesi). Babbo Natale è diventato un fenomeno di massa in Europa solo dopo la seconda guerra mondiale. La Chiesa lo ha inizialmente osteggiato, vedendo in esso una forma di paganizzazione consumistica che rischia di stravolgere la valenza religiosa della festa. Claude Lévi-Strauss, il grande etnologo francese padre dello strutturalismo, ha dedicato un suo famoso saggio (Babbo Natale suppliziato, trad. it. Palermo, Sellerio, 2002) proprio a un episodio di uccisione simbolica di Babbo Natale, messo in scena dal clero di Digione nel 1951. Ma alla fine l’impossibile sincretismo fra Babbo Natale e Gesù Bambino è stato in qualche modo accettato e passato nella cultura di massa. La caratteristica di questa moderna mitologia è che, diversamente da quella religiosa, non viene creduta vera: o meglio, gli adulti la elaborano sorridendo e la fanno però credere ai bambini; tanto che il “credere in Babbo Natale” è uno dei tratti demarcanti dell’infanzia (ma chissà se i bambini, ormai totalmente smaliziati, non fanno a loro volta solo finta di crederci).
Doni. Che l’esperienza natalizia susciti stati affettivi ed emozioni particolari è abbastanza ovvio. Questo vale soprattutto per i bambini, che sono trascinati in un clima “magico” caratterizzato dall’apparizione di una presenza misteriosa e dall’arrivo di doni percepiti come particolarmente preziosi. Un clima caratterizzato da gioia e meraviglia ma anche da una componente di paura (nelle sue versioni pre-consumistiche, il Natale può portare doni ma anche punizioni, come ancor oggi si dice da noi che la Befana può portare il carbone). Ma anche per gli adulti il Natale implica esperienze non ordinarie, in particolare di due tipi. Primo, forme di scambio che seguono lo spirito del “dono”: si acquistano oggetti particolari e spesso “inutili” per donarli a familiari ed amici, e si ricevono doni più o meno inattesi, in modi che non hanno uguale per tutto il resto dell’anno. Secondo l’argomento critico da cui siamo partiti, il fatto che gli oggetti regalati siano acquisiti sul mercato limiterebbe il loro valore di “doni”, configurandoli come semplici emissari della logica consumistica e del profitto che la muove. In definitiva è certo vero che tutto il mercato natalizio risponde a una logica “capitalistica”. Nondimeno, il fatto che gli oggetti nascano come merci non significa che, nel trasformarsi in regali, essi non acquistino per le persone un valore simbolico e comunicativo (da notare che i pacchetti servono proprio a personalizzare i beni anche più stereotipati, depurandoli del loro status di merci, appunto). Come nella classica teoria del dono di Marcel Mauss, i regali natalizi portano sempre una particella dello “spirito” di chi li dona, e restano un modo importante di alimentare relazioni interpersonali e soprattutto rapporti familiari.
Spreco. Il secondo aspetto dell’esperienza non-ordinaria del Natale riguarda i consumi “smodati” e collettivi. Tutti sanno che Natale è il periodo in cui si spende di più, e in cui ci si concedono piccoli o grandi lussi non permessi nel resto dell’anno. Ma questi beni sono destinati a un consumo collettivo, non individuale. Il cenone della vigilia è l’esempio più calzante di tutto questo. Non si bada a spese e a sprechi, si consumano cibi peculiari (si parla di “dolci natalizi”, e “mangiare il panettone” è diventato sineddoche dell’intero periodo natalizio), ricercati, talvolta esotici. Si mangiano insieme, soprattutto. Cenone e pranzi natalizi sono spesso momenti di ritrovo per famiglie allargate, per nuclei di parentela che si vedono raramente nel resto dell’anno, per cerchie di amicizia che da questi momenti risultano rinsaldate. Spesso si leggono sui giornali commenti moralizzanti sugli sprechi festivi, su quanto cibo viene buttato alla fine delle feste: il che è certo deplorevole, ma del tutto coerente con la logica rituale che in questa occasione particolare condanna il risparmio, il riutilizzo, l’economia. A prevalere è quella logica della dépense di cui parlava Georges Bataille, identificandola come una componente cruciale della nostra concezione del sacro. Sprecare, contrariamente a quanto si pensa, non è la logica che guida i nostri comuni comportamenti di acquisto. L’economia morale del consumo tende semmai al “risparmio” (che non significa soltanto e necessariamente spendere meno): ed è solo sullo sfondo di questa economia morale che possiamo capire il significato dello spreco.
Nonni, bambini, generazioni. Dunque, il Natale ha tutte le caratteristiche di un rito contemporaneo, in buona parte profano – forse il rito, o il complesso mitico-rituale, più importante nella nostra società di oggi. Lo è non in virtù delle sue origini, peraltro complesse e del tutto sincretiche (per un’analisi di questo tipo rimando al bel libro di Martyne Perrot, Etnologia del Natale, trad. it. Genova, Elèuthera, 2001); ma per le caratteristiche strutturali che presenta qui e ora, e che, come detto, non possiamo comprendere se non in relazione al sistema culturale e morale, oltre che economico, incardinato su quei consumi di massa che dominano la nostra vita. Il riferimento a più lontane origini o fenomeni simili in culture diverse dalla nostra – cioè la mossa più tipica della comprensione antropologica – serve semmai a suggerirci interpretazioni, a far vedere significati che possono sfuggirci proprio perché ci sono troppo familiari. Chiudo allora, in questa chiave, citando la fascinosa lettura che Lévi-Strauss propone nel saggio sopra citato. Attraverso raffronti storici ed etnologici, egli ritiene che il Natale come rito si incentri attorno al tema dei bambini come mediatori fra generazioni e come elementi di passaggio tra vita e morte, tra mondo terreno e aldilà. Lo raffronta a questo proposito alle feste degli indiani Pueblo del sud-ovest degli Stati Uniti, nei quali i katchina, spiriti di antenati, tornano sulla terra ciclicamente per compiere cerimonie e per punire o premiare i bambini. Una comparazione solo apparentemente estraniante o “primitivista”. Il senso ultimo di entrambi i riti sembra sia quello di venire a patti con l’idea della morte e il passaggio delle generazioni. Cosicché, scrive Lévi-Strauss, “i regali natalizi rimangono un sacrificio autentico alla dolcezza di vivere, la quale consiste innanzitutto nel non morire; …[sono una] preghiera tutta piena di scongiuri che ogni anno, e sempre più, noi indirizziamo ai bambini – incarnazione tradizionale dei morti – perché acconsentano, credendo in Babbo Natale, ad aiutarci a credere nella vita”.