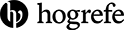Osservatorio Talent
Essere consulenti in un momento di crisi
Essere consulenti in un momento di crisi
R. In realtà penso che essere consulenti implichi necessariamente il fatto di operare in situazioni di crisi, di cambiamento: che si tratti di un cambiamento subìto, promosso, o semplicemente auspicato, per il consulente il terreno in cui muoversi è comunque un terreno non del tutto definito, instabile. Cerco di spiegarmi meglio: affrontare la crisi, secondo una prospettiva più ampia, significa essenzialmente essere disposti a mettere in discussione quei modelli su cui prima avevamo costruito il nostro modo di essere e di agire. Se partiamo da questo presupposto, anche la consulenza in tempo di crisi, e non solo, richiede una grande apertura e flessibilità nel modo di impostare un intervento in ambito organizzativo. Ciò, a mio parere, rende fondamentale sapersi muovere con un certo dinamismo all’interno di realtà organizzative sempre più destrutturate, nelle quali non è facile avere dei parametri di riferimento consolidati, ma dove occorre definirne costantemente di nuovi. In altri termini, un consulente deve saper gestire una moltitudine di variabili, spaziando agilmente dai contenuti di carattere tecnico, nel nostro caso quelli relativi alla psicologia del lavoro, a quelli di natura prettamente economica ed organizzativa; deve saper andare il più possibile incontro alle richieste di aziende che, anche a causa della crisi economica, tendono ad essere sempre più attente e sensibili ai costi, senza per questo e mi permetto di aggiungere fortunatamente, essere in molti casi disposte a rinunciare alla qualità dei servizi acquistati.
D. Qual è l’atteggiamento verso i test nelle aziende con cui lavora?
R. Da questo punto di vista lo scenario è abbastanza eterogeneo. Nelle aziende più strutturate dove è presente una funzione HR attenta ad un’efficace gestione dei processi di selezione, formazione e sviluppo delle persone, devo dire che l’utilizzo dei test se non è già una pratica consolidata è quantomeno considerato una valida metodologia per garantirsi delle valutazioni oggettive ed affidabili. In altre realtà, dove invece il presidio sulle risorse umane è essenzialmente di natura amministrativa e giuslavoristica, capita talvolta di osservare un atteggiamento verso i test, per così dire, un po’ “resistente”. Spesso in questi casi, più che uno scetticismo verso il test in sé, credo che il problema di fondo sia la mancanza di una cultura della valutazione.
Rispetto a questo punto è utile sottolineare che quando si parla dell’utilizzo dei test in azienda, è sempre importante riferirci a strumenti scientificamente validati, oltre al fatto che una volta individuati quelli più in linea con i propri fabbisogni, gli stessi siano gestiti da professionisti adeguatamente formati per un utilizzo efficace e deontologicamente corretto, aspetto che, almeno nella mia esperienza, non sembra esser sempre pienamente e diffusamente noto.
D. A volte vengono fatte distinzioni molto nette tra psicologi del lavoro e psicologi clinici. Lei è psicologo del lavoro ma anche psicoterapeuta. La formazione clinica le è utile anche nella sua attività in organizzazione e viceversa?
R. Per quanto io stesso ritenga molto importante aver ben chiara la differenza tra operare in un setting clinico ed uno organizzativo, con tutto ciò che questa distinzione comporta in termini di obiettivi, metodologie e strumenti di lavoro, allo stesso tempo trovo che ci siano non pochi elementi di positiva contaminazione tra i due ambiti, soprattutto tenendo presente il fatto che in entrambi i casi è comunque la Persona ad essere al centro dei nostri interventi e che la promozione della salute organizzativa difficilmente può prescindere da quella dell’individuo. Detto questo, va da sé che avere alle spalle un percorso formativo sia sul versante della psicologia del lavoro che della clinica permetta al professionista di integrare i diversi approcci in maniera più funzionale alle situazioni che si trova a gestire. Per fare qualche esempio, in tanti interventi fatti con il personale d’azienda (dalla formazione d’aula con gruppi di specialist, al coaching individuale con dei manager), dove in ogni caso uno degli scopi principali è quello di sviluppare competenze (soft skills), non ho dubbi sul fatto che le condizioni necessarie per ben “ingaggiare” i partecipanti siano le medesime che in una relazione di cura (setting clinico) contribuiscono a creare una buona alleanza terapeutica. Allo stesso modo, non di rado nei percorsi di psicoterapia capita che i clienti portino questioni riguardanti aspetti dalla loro vita lavorativa e, anche in questo caso, l’esperienza sul fronte della psicologia del lavoro e delle organizzazioni può offrire un contributo piuttosto significativo.
D. Il panorama della consulenza HR è vastissimo. Quali sono quelle attività per cui essere uno psicologo fa la differenza?
R. Che dire… come appartenente alla categoria non vorrei rischiare di apparire troppo autocelebrativo. Scherzi a parte, penso che lavorare con il capitale umano implichi innanzitutto una grande assunzione di responsabilità e, indipendentemente dalle specifiche aree d’intervento, è fondamentale agire con competenza e professionalità. Si tratta di entrare in contatto con la vita delle persone, con le loro emozioni e sentimenti, con i loro valori. Come dicevo in precedenza, il terreno su cui sovente si trova ad operare un consulente HR è molto complesso ed articolato, basti pensare a tutte quelle occasioni in cui le esigenze della committenza (più o meno esplicitate) possono facilmente entrare in conflitto con i bisogni dei destinatari ultimi dei nostri interventi. Quindi, per destreggiarsi con efficacia all’interno di tali dinamiche, è necessario saper cogliere ed elaborare le informazioni che spesso si presentano sotto forma di segnali deboli; occorre capacità di ascolto ed empatia; competenze per cui una formazione psicologica può certamente fare la differenza.