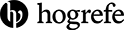Tema del mese
Counseling e Coaching. A che punto siamo in Italia?
Counseling e Coaching. A che punto siamo in Italia?
Quando Rollo May (1909-1994), alla fine degli Anni Trenta, pubblicò la prima edizione del suo famoso L’arte del Counseling (il primo libro pubblicato negli Stati Uniti sull’argomento) aveva alle spalle una significativa ma non ampia esperienza personale e professionale. Ancora oggi i suoi testi – anche sotto la luce della Psicologia Esistenziale – sono noti e studiati nel mondo da diverse schiere di persone, non solo psicologi, ma il suo libro sul counseling sembra aver aperto la via, almeno in Italia, ad una sorta di faciloneria del counseling e ad una tipologia di counselor fai-da-te, fin troppo spesso autoproclamatosi tali. Nulla a che vedere con la storia di vita e la biografia professionale di Rollo May.
È dunque francamente difficile paragonare l’esempio di May e di tanti altri psicologi seri ed impegnati come lui – anche di età contemporanea come, ad esempio, John McLoad, autore delle settecentocinquanta pagine della quinta edizione di An Introduction to Counselling (recensito in Qi. Questioni e Idee in Psicologia, n. 33, 2015) – con la schiera informe di soggetti laureati e, spesso, nemmeno laureati, che, oggi, si proclamano counselor nel nostro Paese. Così come non depone a favore il sorgere delle tante scuole di counseling (e di coaching), esattamente come non fu un evento felice il progressivo sorgere delle attuali oltre trecento scuole di psicoterapia prima ancora della definizione legislativa della professione di psicologo, decenni addietro (Castiello d’Antonio, 1983). Nel quadro globalmente confuso che ben presto si è venuto a creare si sono perse le cognizioni delle origini sia del counseling, sia del coaching. Il counseling sembra così essere spuntato nel tardo Novecento, dimenticando le radici che affondano nei primi anni di quel secolo, nella Vocational Guidance, nei programmi sociali e sanitari rivolti alla salute mentale, nel generale sforzo della psicologia (ma non solo) di “rendersi utile” alle persone, negli USA, e successivamente in UK. Da quelle esperienze emerse, tra gli altri, il counseling organizzativo, mentre il coaching faceva la sua apparizione sotto forma di consulenza manageriale finalizzata ed esperta – nulla a che vedere con la visione che vede il coaching nascere dal tennis… (Biggio, 2007; Castiello d’Antonio, 2013, 2014) –.
Circa il counseling, ad esempio, il lavoro scritto da Tracy A. Prout e Melanie J. Wadkins (2014) presenta al lettore un completo panorama delle tecniche di colloquio di counseling e delle competenze specifiche che il professionista dovrebbe possedere. Fondato intorno ad una serie di indicazioni che sono state sviluppate in diversi ambiti associativi e programmi di formazione nordamericani e internazionali, il testo illustra come poter integrare i differenti approcci al counseling e al colloquio di counseling al fine di andare incontro alle necessità del cliente e assolvere il ruolo di intervistatore nel modo più appropriato possibile. Tutto ciò nel rispetto del mandato istituzionale e/o organizzativo.
Il testo ha una connotazione di genere clinico ma la quasi totalità delle indicazioni che sono offerte può essere applicata proficuamente agli ambiti sociali e del lavoro, e alle necessità che incontrano regolarmente il counselor e il coach nel gestire il processo con il proprio cliente.
Uno degli aspetti più interessanti di questo lavoro è costituito dalla panoramica globale degli approcci al counseling basati sulle principali scuole di pensiero: psicodinamico, comportamentale e cognitivo, umanistico, sistemico, senza trascurare la prospettiva integrativa. Se il counseling può essere applicato secondo le tante e diverse teorie psicologiche, esattamente lo stesso avviene per il coaching: esiste oggi un’ampia letteratura che testimonia in modo specifico ogni singola applicazione teorica e metodologica agli ambiti del counseling e del coaching. In sostanza, entrambe queste attività risultano, da un lato, ad intenso contenuto scientifico e professionale ma, dall’altro, emergono continuamente come banalizzate e svilite in una miriade di approcci che non hanno nulla a che vedere con l’etica e la competenza psicologiche.
Vi è poi la terza dimensione, trasversale, che accomuna counseling e coaching – e, naturalmente, tutte le psicoterapie – cioè la dimensione della relazione tra esperto e cliente, iniziando con il come aprire il primo colloquio e come proseguire nell’esplorazione delle tematiche che caratterizzano la storia e l’identità del soggetto consultante. Qui emergono le diverse posizioni cognitive ed emotive che può assumere il professionista, dando spazio all’ascolto, al rispecchiamento e alla riflessione congiunta sviluppabile con il cliente e – come in ogni (buona) azione di consiglio, di “cura”, e di formazione – si apre l’argomento del cambiamento. Come fare a promuovere il cambiamento della persona? Ad indirizzarla verso il risanamento, il miglioramento e il consolidamento delle proprie capacità? E a far tutto ciò “semplicemente” parlando con la persona? La tematica della teoria e della tecnica del colloquio emerge in tutta la sua importanza (Castiello d’Antonio, 2015; Del Corno, Lang, 2002; Kadushin, 1972; McWilliams, 1999; Semi, 1985, 1992), mentre sia il counseling, sia il coaching si prestano ad essere studiati per mezzo di quei mixed methods che sono recentemente propugnati al fine di superare la contrapposizione tra qualitativo e quantitativo.
Intorno a tutti questi argomenti aleggiano le riflessioni e le iniziative su come formare un buon counselor e un buon coach (cfr. Mucchielli, 1983): quali sono le capacità di base per svolgere tali professioni e come si costruiscono e come si apprendono? Si tratta di una tematica scottante in particolare in Italia, un Paese in cui manca del tutto un minimo di regolamentazione per attività che vorrebbero porsi ai lati della psicologia applicata e che però comportano una forte connotazione psicologica e psicosociale. Oggi chiunque può autodefinirsi counselor o coach spesso avendo soltanto acquisito un titolo prodotto a valle della frequentazione di scuole o “master” di pochi mesi, ed essendo persino privo di un qualunque diploma di laurea. Così, solo per fare alcuni esempi, dirigenti d’azienda che hanno sperimentato il coaching come clienti si improvvisano loro stessi “coach”, pensionati desiderosi di occupare il tempo libero si propongono nelle vesti di “counselor”, e giovani neolaureati privi di una qualunque esperienza non solo professionale, ma anche di vita, si ergono nelle vesti di “consulenti di…”. Non essendoci, in Italia, una solida tradizione di servizio sociale, il campo del counseling e del coaching è al momento occupato da una miriade di figure improvvisate il cui impatto nel mondo organizzativo, sociale ed istituzionale comporta un’infinità di problemi tra i quali l’aver ridotto nel giro di pochi anni queste attività a una specie di giochino in cui chiunque può sperimentarsi. Non a caso ci sono persino soggetti che si propongono a costo zero perché devono “fare esperienza”, oppure cumulare un certo numero di ore di coaching per ambire al conseguimento del diploma di coach rilasciato, immancabilmente, da una delle tante “scuole” di formazione.
Ricordo, all’incirca quindici anni fa, di aver segnalato con una email ai principali ordini regionali di psicologia il pericolo nascente di un “coaching selvaggio”, proposto da chiunque e privo di ogni base scientifica e professionale: non ebbi alcuna risposta – “naturalmente!”, come alcuni colleghi commentarono…–. Oggi che il coaching e il counseling sono diventati il far west è la magistratura che mette ordine, intervenendo su aspetti che per noi psicologi dovrebbero essere acquisiti almeno da quando è stata promulgato in Italia l’ordinamento della professione di psicologo. Così sono le sentenze dei tribunali che devono ricordare a tutti noi che la diagnosi psicologica è affare di psicologi, che il prendersi in carico una persona in difficoltà – al di là dei fantasmagorici termini che si possono usare – è psicologia applicata, cioè clinica, cioè psico-terapia, e che quindi una tale, sedicente, “psicosomatista di impresa” non può condurre operazioni psicologiche se non è in possesso di diplomi ed abilitazioni perché incorre nell’esercizio abusivo della professione (vedi la sentenza 433 del 15 marzo 2016 della Suprema Corte di Cassazione).
È inoltre ridicola la motivazione spesso adottata da chi non è psicologo e che svolge ogni genere di intervento sulle persone nei contesti sociali, cioè che non ci si occupa di aspetti “malati” della persona. In primo luogo, in base a quali competenze il soggetto – ad esempio, il counselor non psicologo – decide che il suo cliente non ha tratti psicopatologici? Se lo fa, compie una diagnosi psicologica, e quindi ricade nell’esercizio abusivo della professione. Se non compie una diagnosi, non può sapere se e quanto il cliente manifesti difficoltà psicologiche. In secondo luogo, la netta scissione tra chi sarebbe “sano” e chi sarebbe mentalmente “malato” sembra essere resuscitata dalle tenebre di un paio di secoli fa… In tutti i contesti della vita reale – scuole, organizzazioni di lavoro, ambiti sociali e sanitari, istituzioni – i tratti e le tipologie umane si presentano come una fusione di caratteristiche funzionali e disfunzionali: alcune qualità che ricadono in questo secondo comparto sono definibili schiettamente psicopatologiche, mentre altri tratti apparentemente “normali” possono nascondere disturbi mentali non lievi (si veda Lowman, 1993). La netta distinzione tra sano e malato in psicologia non ha molto senso specificatamente nell’ambito delle nevrosi e dei disturbi di personalità di cui la realtà sociale è piena.
Ciò che impressione in questo panorama è constatare che persino gli psicologi non hanno le idee chiare su tali questioni, oppure la pensano esattamente come i “selvaggi”: ricordo un dibattito sulla selezione delle risorse umane avvenuto un paio di decenni fa in cui diversi psicologi sostenevano che per fare i colloqui di selezione al fine di valutare le caratteristiche soggettive dei candidati non fosse importante essere psicologi ma sarebbe stato sufficiente avere sensibilità, saper ascoltare e manifestare empatia… Un po’ come dire che per fare un intervento chirurgico non è necessario essere medici-chirurghi ma è sufficiente una buona abilità manuale, vederci bene, e non impressionarsi di fronte al sangue… Non a caso alcuni psicologi, tutt’oggi, ritengono che il counseling e il coaching possano essere esercitati anche da non-psicologi, così come altri ritengono che sia inutile continuare a insistere sulla necessità di impiegare psicologi nelle attività tipiche della psicologia del lavoro (assessment, training, consulenza di sviluppo in area H.R.), ritenendo ormai “perso” questo settore di attività a favore dei tuttologi. E che dire degli psicologi accademici che – pur continuando a laureare migliaia di giovani nelle diverse aree della psicologia – non hanno mai sentito la necessità di spendersi pubblicamente in difesa dei confini della professione psicologica?
Dunque, il momento attuale della definizione del coaching e del counseling in Italia, vede l’emergere delle sentenze dei tribunali come elemento organizzatore della materia sul versante della professione e dell’accesso alla professione, mentre tra gli stessi addetti ai lavori, professionisti ed accademici, non sembra esserci consenso su numerosi temi di fondo.
Bibliografia
- Biggio G. (2007). Il counseling organizzativo. Raffaello Cortina, Milano.
- Castiello d’Antonio A. (1983). Osservazioni sulle “Nuove Scuole” di psicoterapia in Italia. Giornale Italiano di Psicologia, X, 2, 381-394.
- Castiello d’Antonio A. (2013). Il Coaching. Risorse Umane nella Pubblica Amministrazione, XXVII, 6, 55-70.
- Castiello d’Antonio A. (2014). Il contributo della psicologia positiva al coaching psicologico. Counseling. Giornale Italiano di Ricerca e Applicazioni, 7, 1, 19-31.
- Castiello d’Antonio A. (2015). Interviste e colloqui nelle organizzazioni. Metodi per un dialogo efficace nei contesti organizzativi e istituzionali. Raffaello Cortina, Milano.
- Del Corno F., Lang M. (2002). Modelli di colloquio in psicologia clinica. FrancoAngeli, Milano.
- Kadushin A. (1972). Il colloquio nel servizio sociale. Astrolabio, Roma, 1980.
- Lowman R. L. (1993). Counseling and Psychotherapy of Work Disfunctions. American Psychological Association, Washington, Washington.
- May R. (1939). L’arte del counseling. Astrolabio, Roma, 1991.
- McLeod J. (2013). An Introduction to Counselling. V Edition. Open University Press. mcGraw-Hill Education, Maidenhead.
- McWilliams N. (1999). Il caso clinico. Dal colloquio alla diagnosi. Traduzione italiana a cura di Raffaello Cortina, Milano, 2002.
- Mucchielli R. (1983). Apprendere il counseling. Traduzione italiana a cura di Erickson, Trento, 1987.
- Prout T.A., Wadkins A.J. (2014). Essential Interviewing and Counseling Skills. Springer Publishing Company, New York.
- Semi A.A. (1985). Tecnica del colloquio. Raffaello Cortina, Milano.
- Semi A.A. (1992). Dal colloquio alla teoria. Raffaello Cortina, Milano.