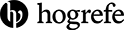L'intervista
Intervista a Salvatore Soresi
Intervista a Salvatore Soresi
Dal 5 al 7 ottobre si terrà a Padova un congresso internazionale dal titolo “Counseling and Support. Decent Work, Equity and Inclusion. Passwords for the Present and the Future” (ne è chair la prof.ssa Laura Nota). L’evento, per il quale si aspettano oltre 500 partecipanti, è stato preceduto da un lungo lavoro preparatorio che ha portato alla stesura di un Manifesto per l’inclusione, sottoscritto da circa 600 fra professionisti, operatori e studiosi di vari Paesi, che sarà lanciato durante il congresso. Del convegno, dei temi che vi verranno discussi (inclusione, uguaglianza e lavoro dignitoso), ma soprattutto delle ragioni e delle ambizioni che stanno alla radice del Manifesto, parliamo con Salvatore Soresi, che ne è il principale animatore.
D. Da tempo, assieme alla prof.ssa Laura Nota e al suo gruppo, si occupa di “decent work”. Cosa si intende con questa espressione e quali sono le finalità dell’attività di ricerca che voi, ma non solo voi, state svolgendo al riguardo?
R. La definizione di decent work maggiormente gettonata è senza dubbio quella proposta dall’ILO (l’Organizzazione internazionale del lavoro dell’ONU), che suggerisce di considerare dignitoso solamente quel lavoro che è tutelato da norme che regolamentano l’orario, precisandone il massimo di ore giornaliere e settimanali; definiscono modalità di prevenzione della disoccupazione, l’adeguatezza dei salari, la tutela da malattie ed infortuni, la protezione dei bambini e delle donne, il pensionamento, la protezione dei lavoratori emigrati, l’uguaglianza del salario in presenza di lavori di ugual valore, la libertà di associazione, l’organizzazione e la fruibilità dell’educazione professionale e tecnica. Fornendo questa definizione, l’ILO si è proposta di invitare i governi di tutti i paesi a dotarsi di norme di gestione ed organizzazione del lavoro in sintonia con le raccomandazioni internazionali per “promuovere opportunità per uomini e donne affinché possano ottenere un lavoro dignitoso e produttivo, in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità umana”.
Al Larios (Laboratorio di ricerca e di intervento per l’Orientamento alle scelte dell’Università di Padova) e con il concorso della SIO (Società Italiana per l’Orientamento) e il supporto di UniCo (Network Universitario per il Counseling), nell’avviare una serie di occasioni di studio e di ricerca in materia, ci siamo trovati spesso a riflettere sull’opportunità o meno di ancorarci a questa definizione sia a livello di ricerca che di proposta di azioni di orientamento e di supporto alla scelta e alla progettazione professionale. Considerando tutto sommato quella dell’ILO una demarcazione tra lavori (e “datori di lavoro”) legali e illegali, rispettosi o non dei diritti e delle dignità umane, molti di noi preferiscono parlare di “buon lavoro”. Questo, a differenza del decent work dell’ILO, enfatizza la centralità delle determinanti contestuali e culturali che oltre a portaci a dubitare dell’opportunità di sostenere ipotesi di “esportazione della democrazia” – ci sono importanti studiosi di diritto internazionale che iniziano ad allertare riguardo al pericolo insito in quello che è stato definito “colonialismo dei diritti umani” –, ci hanno analogamente portato a considerare fuorvianti tutti quei modelli che propongono componenti e dimensioni che, provenendo da contesti diversi, pretendono arbitrariamente di essere in grado, anche se derivanti da analisi cross-culturali, di fornire letture e suggerimenti “universali” in assenza di quei coinvolgimenti e quelle partecipazioni che sarebbero in grado di valorizzare le specificità delle comunità e delle culture, la loro autodeterminazione e i loro diritti alla co-costruzione di visioni della qualità della vita e degli sviluppi auspicati per le loro comunità.
D. Cosa intendete dunque con l’espressione "buon lavoro"?
R. Quella che all’interno del Larios ci piacerebbe diventasse oggetto di riflessione condivisa e di ricerca, fa riferimento da un lato ad alcune suggestioni provenienti da modalità non occidentali di definizione del lavoro, e dall’altro a quelle visioni dello sviluppo che enfatizzano la condivisione e la partecipazione, piuttosto che a visioni di tipo prevalentemente neoliberiste e competitive regolate dalle cosiddette leggi di mercato. Da questo punto di vista, il concetto di buon lavoro che vorremmo sottoporre a ricerca e promuovere rifiuta tanto ogni forma di “imperialismo disciplinare” di tipo, ad esempio, economico o psicologico, quanto ogni pretesa di applicabilità generalizzata in ogni contesto, in ogni comunità, in ogni dove e in ogni quando di visioni che si distanziano significativamente da quelle prettamente occidentali e neoliberiste. Riteniamo infatti che un lavoro può essere considerato un buon lavoro solamente se:
a) È stato scelto in modo sufficientemente consapevole, autonomo e in assenza di pressioni ineludibili. Un lavoro potrà essere considerato un “buon” lavoro se risulterà in sintonia con le idee di fondo che sostengono l’idea di benessere delle persone, la loro concezione della vita e, nello specifico, la costruzione del loro personale progetto professionale, come direbbero i costruttivisti e gli studiosi del life design. A queste condizioni il lavoro, probabilmente, potrà essere considerato effettivamente importante per le concrete possibilità che offre a di utilizzazione e di sviluppo delle capability delle persone, come direbbe Amartya Sen, dei loro interessi e valori professionali, come direbbero molti studiosi del vocational guidance.
b) Un lavoro così inteso e soprattutto così percepito potrebbe essere ritenuto da una persona un “buon lavoro” in quanto sarebbe al contempo percepito anche come “socialmente prestigioso”, qualcosa di cui poter andare orgogliosi, “da difendere e promuovere” apertamente per il suo intrinseco valore sociale, interpersonale, umano e per il contributo che fornirebbe ad uno sviluppo auspicabile e condiviso in quanto pensato e definito “dal basso”, in seguito a processi e dinamiche di tipo partecipativo. Da questo punto di vista, ad esempio, potrebbe difficilmente essere considerato un buon lavoro quello che contribuisce alla produzione, propaganda, commercializzazione e diffusione di agenti inquinanti, di armi, ma anche di prodotti diversi di dubbia sicurezza e qualità.
c) Un buon lavoro, in altri termini, deve essere significativo di per sé, deve consentire la mobilitazione delle migliori competenze possedute da ciascun lavoratore ed essere un potente generatore di relazioni, di partecipazione alle decisioni aziendali, di soddisfazione e gioia se non proprio di felicità. In sintonia con tutto questo, un posto di lavoro non potrà essere considerato un “buon posto” se i lavoratori sono costretti a sottoscrivere contratti che li impegnano a “non parlar male dell’azienda”, a non minarne l’immagine e la reputazione o se, di fatto, è per loro particolarmente rischioso assumere le vesti di un whistleblower [informatore], a causa di probabili rappresaglie cui sarebbero oggetto nel caso decidessero di “soffiare il fischetto”, di dare l’allerta per la presenza di “azioni fallose”, di discriminazioni, di ingiustizie che potrebbero aver osservato nel proprio contesto lavorativo. Un buon lavoro e un buon posto di lavoro, soprattutto in “società del rischio” come quelle in cui stiamo vivendo, dovrebbero consentire a tutti i lavoratori di “lanciare l’allerta”, di farsi portavoce della probabile presenza di pericoli per la sicurezza e la salute di persone e contesti, come hanno fatto quei lavoratori che hanno, ad esempio, sollevato dubbi sui rischi associati al nucleare, all’amianto, alla mucca pazza, a questo o quel farmaco, ma anche a questa o quella modalità di gestione ed organizzazione delle condizioni di lavoro.
Questi tre elementi sono purtroppo pressoché assenti nei nostri programmi di orientamento e nelle azioni delle nostre agenzie del lavoro: su essi si dovrà fare molta ricerca, molta formazione, sperimentazione e mettere a punto nuovi percorsi di consulenza in favore, anche, dei decisori, delle imprese e delle organizzazioni.
D. Fra pochi giorni si terrà a Padova un convegno internazionale dedicato al tema, appunto, del lavoro dignitoso, ma anche dell’inclusione. Temi sicuramente attuali in un contesto di incertezza, di cambiamenti politici, economici e sociali come quello che stiamo vivendo. Ma ci pare che vogliate intendere “inclusione” in un senso il più ampio più possibile: ci spiega meglio?
R. Oggi tutti, anche se con distinguo a proposito delle condizioni da porre in essere, sembrano parteggiare per l’inclusione. Paradossalmente ne parlano sia coloro che propongono condizioni più o meno severe alla libera circolazione delle persone, sia coloro che ne parlano in modo assoluto, universale, senza eccezioni, senza “se” e senza “ma” richiamandosi alla lettera a quanto già sancito nel 1948 dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (“Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio; ognuno ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione; ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia; alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità …”).
Se persone diverse utilizzano la stessa parola intendendo di fatto cose anche marcatamente diverse, incrementando ulteriormente luoghi comuni, confusioni, manipolazioni e strumentalizzazioni e se tutto questo avviene anche in buona fede, qualche responsabilità, probabilmente, va addebitata anche al fatto che il costrutto dell’inclusione è particolarmente complesso e facilmente confondibile con quello di inserimento ed integrazione. L’inserimento,in poche parole, garantisce il diritto alla fruibilità di spazi e servizi comuni ai gruppi minoritari (persone con alcune tipologie di disabilità, extracomunitari, migranti, persone con problemi di salute mentale, ecc.). Si propone di ridurre il rischio di istituzionalizzazione ed emarginazione puntando a favorire, come negli anni ’70 aveva indicato il cosiddetto “modello a cascata” (the cascade system), il diritto di tutte le persone a ricorrere ai servizi comuni di tipo educativo, riabilitativo e sociosanitario in condizioni ambientali sempre meno restrittive, indipendentemente dall’appartenenza a questo o a quel gruppo minoritario o dall’etichetta diagnostica ricevuta. I luoghi della cura e della riabilitazione, ma anche quelle della formazione e del lavoro dovrebbero essere comuni, non “specialmente” riservati a questa o quella tipologia di cittadini. Le “parole” e le espressioni dell’inserimento riguardano pertanto “lo stare vicino a”, “l’essere visibili”, “l’utilizzare gli stessi spazi e condividere gli stessi tempi degli altri” pur continuando a ricevere, nei contesti comuni, le attenzioni di cui si necessita grazie alla regolamentazione, potremmo dire, di quel “dilemma delle differenze” che dovrebbe portarci a declinare in modo soddisfacente uguaglianza e differenza ricordando anche, come ammoniva don Milani, che “non c’è nulla che sia ingiusto quanto far le parti uguali tra diseguali”. Parliamo molto di inclusione dimenticando che anche da noi il diritto alla frequenza dei contesti comuni, non aventi restrizioni e confini appositamente pensati per “difendere e trattare in modo adeguato” alcune persone (con alcune tipologie di disabilità, ma non solo) è ancor oggi piuttosto frequente: basti pensare a quelle centinaia di migliaia di persone che sono, ancor oggi, “inserite”, “ricoverate”, “educate” in luoghi separati, in centri, cooperative speciali, più o meno sociali, in “case famiglie artificiali” e che, stando ai dati ufficiali dell’ISTAT, nelle nostre scuole gli studenti con disabilità continuano a trascorrere fuori dalla classe comune mediamente oltre il 20% del tempo scolastico.
C’è molto ancora da fare per l’inserimento, anche in Italia, dal momento che questo non è ancora certamente generalizzato e che sono addirittura numerose e in aumento le richieste e le proposte di luoghi separati per questa o quella tipologia di persone e tutto questo, spesso, con il sostegno di associazioni e specialisti!
L’integrazione non si accontenta del permettere lo stare accanto; propone l’interazione, “il fare con…”, “l’assieme a…”, “con il concorso di…”, nel rispetto di qualche forma di reciprocità per il perseguimento di obiettivi comuni, nello svolgimento di compiti importanti per un determinato gruppo o comunità. L’integrazione presuppone ovviamente l’inserimento, ma richiede anche collaborazione, condivisione di scelte, autonomia e competenze. Siccome il semplice inserimento non garantisce alle persone in difficoltà la sperimentazione di successi confrontabili a quelli della maggior parte delle persone, l’integrazione richiede che si mobilitino servizi e professionalità per supportare, sostenere, agevolare, tramite interventi straordinari di tipo “dispensativo” e “compensativo”, il permanere in modo attivo delle persone maggiormente vulnerabili, all’interno dei contesti comuni e, in primis, in quelli propri della salute, della formazione e del lavoro. E anche su questo c’è ovviamente ancora molto da fare!
L’inclusione non si accontenta di considerare l’integrazione di alcune persone e le interazioni che si registrano in un determinato contesto, ma è interessata anche alle “condizioni”, alle caratteristiche degli ambienti che, se inclusivi, dovrebbero essere strutturati, costruiti in modo tale da essere effettivamente fruibili in modo efficace, senza ostacoli e barriere di diverso genere, da tutti tramite partecipazioni attive e livelli soddisfacenti di vita. Se l’inserimento e l’integrazione pongono al centro della propria attenzione e privilegiano alcune categorie di persone, richiedendo servizi ad hoc per loro, l’inclusione considera esplicitamente, con la stessa insistenza, il diritto di tutti a ricevere le attenzioni, le flessibilità e gli adattamenti di cui necessitano denunciando le inadempienze che al riguardo si possono costatare in questo o quel contesto, in questa o quella comunità. Da questo punto di vista la presenza di professionalità esclusivamente dedicate a gruppi minoritari e di servizi esclusivi per qualcuno si può trasformare in una vera e propria barriera all’inclusione e alla partecipazione così come, tra l’altro, si è espresso anche l’UNESCO quando ha affermato che la mancanza di cambiamenti organizzativi ha dimostrato di essere una delle maggiori barriere all’implementazione di politiche inclusive (Unesco, 2005). Le parole e le espressioni proprie dell’inclusione, a differenza di quelle dell’inserimento e dell’integrazione, che si focalizzerebbero prevalentemente sui diritti di gruppi minoritari di persone in difficoltà e sulla disponibilità professionali di specialisti, sarebbero, come direbbe S. Agostino, da un lato sature di “indignazione” per come i contesti costringerebbero alcune persone a sottoporsi e piegarsi a “condizioni” e barriere, spesso burocratico-amministrative, per poter fruire delle attenzioni personalizzate di cui avrebbero diritto e, dall’altro, di quel coraggio che è sempre più necessario quando si tratta di indicare in modo “manifesto” responsabilità, inadempienze e nell’indicare i cambianti necessari che i diversi contesti dovrebbero approntare per consentire a tutti una vita di qualità che richiede anche empowerment, partecipazione, autodeterminazione, consapevolezze e condivisioni. L’inclusione non ammette scorciatoie, soluzioni lineari, semplici, standardizzate, non ammette confini, dogane, “prove d’accesso” e dovrà dinamicamente farsi strada dentro e fuori le scuole e le università, riguardare lo studio come il lavoro e il tempo libero… l’inclusione è una rotta, una meta, una sfida… è, probabilmente, un sogno, una chimera che non si realizzerà mai in modo completo e una volta per tutte. Fortunatamente, però, come in una bella ninna nanna suonava e cantava Gianmaria Testa, “solo i sogni non dormono mai!”.
D. Nel corso del convegno sarà presentato un Manifesto su questi temi: perché questa iniziativa, chi ne sono i promotori e gli attuatori, e cosa vi aspettate da esso?
R. Le ragioni di questa iniziativa sono diverse e molte derivano da una serie di riflessioni che da qualche anno a questa parte abbiamo compiuto all’interno del Centro di Ateneo per la Disabilità e l’Inclusionedell’Università di Padova. Lavorando in favore dell’inclusione in diversi contesti, da quelli formativi a quelli lavorativi e sociali, abbiamo constatato che spesso anche i ricercatori e i professionisti del counseling non esprimono in modo chiaro, manifesto appunto, sentimenti, convincimenti, valori, sentimenti, convincimenti, ma anche le proprie capacità e competenze, propositi ed impegni, che sono disposti ad assumere in favore dell’inclusione. Si avverte spesso il bisogno, in altre parole, di disporre ed offrire una sorta di checklist in grado di consentire di controllare, di volta in volta, anche la qualità degli interventi che di fatto si realizzano e il grado di raggiungimento degli obiettivi che, in nome dell’inclusione, vengono individuati, scelti e definiti.
Tutto questo richiede anche al counseling, alle scienze dell’orientamento e della formazione, all’economia, ai servizi e alle professioni interessate al benessere e al futuro delle persone, nuovi sforzi, nuove visioni, diverse sensibilità, competenze alternative da stimolare e mettere in circolo. Devono contribuire maggiormente alla sperimentazione di soluzioni e di buone pratiche per ridurre significativamente il numero di coloro che sono a rischio di espulsione, dal lavoro, dalla formazione, dalle comunità, o che potrebbero vedersi negato o affievolito il diritto alla cittadinanza attiva. Occuparsi di tutto questo è particolarmente urgente in quanto le iniquità che si stanno osservando tra Paesi e tra persone potrebbero aumentare ulteriormente se non saranno abbracciate, con decisione e generosità, scelte e contromisure efficaci. Abbiamo organizzato l’International Conference di Padova e lanciata l’idea del Manifesto in quanto, molto sinteticamente, riteniamo opportuno che anche gli studiosi e i professionisti del counseling e dell’inclusione si facciano sentire per a) richiedere ed avviare una crescita sostenibile ed inclusiva, che ponga effettivamente al centro del dibattito la questione della dignità e del rispetto dei diritti umani; b)promuovere la messa a bando di ogni forma di discriminazione e disuguaglianza.
Il Manifesto che sarà ufficialmente presentato a Padova rappresenta lasintesi del punto di vista di oltre 600 studiosi e professionisti provenienti da diverse parti del mondo che hanno accettato di reagire ad una serie di stimoli che avevamo predisposto per consentire loro di esprimere pensieri, preoccupazioni e propositi a proposto dell’inclusione. Utilizzando procedure diverse di analisi dei testi raccolti, il nostro Manifesto, dopo un preambolo che ne ricorda le finalità e gli obiettivi, risulta articolato in tre sezioni:
- la prima fa riferimento ad alcuni importanti indicatori della presenza di un contesto inclusivo (Un contesto può essere considerato inclusivo solamente se…);
- la seconda sezione presenta un insieme di attività, azioni ed iniziative che dovrebbero essere presenti in un contesto effettivamente inclusivo (I contesti che intendono promuovere l’inclusione dovrebbero…);
- la terza parte, infine, fa riferimento ai propositi e agli impegni che i ricercatori e i professionisti del counseling e dell’inclusione intendono assumere in prima persona per promuovere sempre più, nei propri ambienti di vita e di lavoro, l’inclusione, per rimuovere ostacoli e barriere, per ricercare collaborazioni, alleanze, ecc. (In qualità di studioso e di professionista mi impegno a…).
Quanto sopra, oltre a fornire al tema dell’inclusione una sorta di “validità di contenuto”, contribuendo a precisarne il costrutto e a differenziarlo da altri, suggerirà la messa a punto di strumenti di analisi e di valutazione, piste di ricerca e di lavoro per l’ideazione e realizzazione di ulteriori progetti e la sottoscrizione di impegni professionali da onorare.
È ciò di cui, d’altra parte, si discuterà proprio l’ultimo giorno del convegno quando saranno presentati progetti di ricerca, di sperimentazione e cooperazione internazionale in favore dello sviluppo del “buon lavoro”, dell’equità e dell’inclusione e quando, ogni partecipante, sarà invitato a sottoscrivere il Manifesto e a scegliere, tra i suoi 33 articoli quelli maggiormente vicini al proprio modo di concepire la propria professione.
I miei, e particolarmente impegnativi, sono questi tre:
a) “…l’dea di inclusione va difesa da quanti tendono ad utilizzare questo termine in modo superficiale, scorretto e strumentale, associandola quasi esclusivamente ad alcune tipologie di persone e di contesti…” (art.1);
b) va enfatizzato il ricorso “a mansionari, a protocolli e a pratiche che si adattino alle storie delle persone, dei gruppi e dei contesti e non viceversa, senza ricorrere a norme speciali appositamente pensate per questa o quella tipologia di persone o difficoltà…” (art.20)
c) mi impegno a “fare da sentinella dell’inclusione, a stare all’erta… a sostenere con vigore che non sono più disposto a tollerare chi tollera l’intolleranza, …chi pone le persone le une contro le altre o in perpetua competizione magari in nome della legge del più forte, della meritocrazia, delle abilità e delle competenze possedute, o di uno sviluppo ad oltranza improbabile e difficilmente sostenibile” (art.33).
Il Manifesto per l’inclusione e il volume che raccoglie i testi di coloro che con i propri pensieri, propositi ed impegni ne hanno favorito la stesura (Laura Nota e Salvatore Soresi (a cura di) …for a Manifesto in Favor of Inclusion. Concerns, Ideas, Intentions, and Passwords for Inclusion. Firenze: Hogrefe Editore, 2017)sono liberamente scaricabili dal sito del Larios (www.unipd.it/counseling-and-support2017/manifesto).